
ARTE
Per gentile concessione a Nuove Edizioni Bohémien
Un legame inatteso tra Rinascimento e Sol Levante

1.L’annotazione che riscrive la storia
In un passo del Codice Madrid II (87r), Leonardo scrive:
«Si manterranno meglio scortecciati e abruciati in superficie che in alcun altro modo.»
Parole essenziali, ma dal valore rivoluzionario. Fino a quel momento, infatti, i metodi di conservazione del legno erano perlopiù passivi: le palafitte veneziane, ad esempio, si basavano sull’immersione in acqua per sfruttare l’ambiente anaerobico che rallentava la decomposizione. Leonardo, invece, proponeva un intervento attivo: modificare le proprietà del legno attraverso una manipolazione diretta, ovvero la carbonizzazione superficiale.
La sua intuizione anticipava di oltre due secoli il procedimento giapponese dello Shou Sugi Ban (o Yakisugi), documentato solo dal XVIII secolo.
2.Tra Plinio, Vitruvio e Palladio: la cultura dietro l’invenzione
L’annotazione di Leonardo non nasce dal nulla. Il Codice testimonia il suo confronto con i grandi autori dell’antichità:
– Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, descriveva le caratteristiche dei materiali naturali.
– Vitruvio, con il De Architectura, offriva consigli su tempi e modalità di taglio del legname.
– Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, agronomo romano, trattava la coltivazione e la conservazione delle foreste.
Leonardo, “lettore onnivoro”, non si limita a copiare: mette a confronto queste fonti, ne evidenzia le divergenze e integra il tutto con osservazioni pratiche personali. È proprio qui che emerge il suo genio: l’annotazione sulla bruciatura del legno non compare in nessun autore antico, ma rappresenta un’idea originale, frutto di sperimentazione.
3.La scienza dietro la bruciatura
Oggi sappiamo che la carbonizzazione superficiale produce tre effetti fondamentali, perfettamente coincidenti con quanto avviene nello Shou Sugi Ban giapponese:
1. Impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici – Il fuoco elimina l’umidità residua e chiude i pori del legno. Lo strato carbonizzato diventa una barriera contro l’acqua e le variazioni climatiche.
2. Protezione dagli incendi – Paradossalmente, il legno già bruciato in superficie resiste meglio alle fiamme, perché lo strato di carbone rallenta la propagazione del calore.
3. Difesa da insetti e funghi – Il calore elimina zuccheri e componenti nutritive della cellulosa, rendendo il materiale inospitale a parassiti e muffe.
4.Un caso di invenzione convergente
Gli studiosi escludono che Leonardo potesse conoscere pratiche giapponesi: tra il Quattrocento e il Cinquecento il Giappone era pressoché isolato e lo Yakisugi non era ancora documentato.
La coincidenza è dunque straordinaria: due culture distanti, senza alcun contatto, hanno trovato la stessa soluzione tecnica a un problema comune. Un fenomeno noto come invenzione convergente.
Eppure alcuni studiosi si chiedono se gli scambi culturali avviati nel XVI secolo dai navigatori portoghesi e spagnoli possano aver portato tracce indirette delle idee di Leonardo in Oriente. È un’ipotesi affascinante.
5.Leonardo, il legno e le sue mille applicazioni
Per Leonardo il legno non era un materiale qualunque. Nel Rinascimento, esso era la base di ponti, navi, macchine e strumenti musicali. Il Codice di Madrid rivela la sua attenzione per ogni aspetto del materiale:
– Scelta della specie: quercia e rovere per resistenza; frassino e tiglio per flessibilità e leggerezza; ontano e salice per lavori subacquei.
– Stagionatura naturale: lasciare i tronchi “sopra le radici” per far scolare gli “umori” (linfa), riducendo deformazioni e fragilità.
– Uso in architettura: castagno e faggio per “chiavi e catene” murarie, elementi strutturali che rinforzavano gli edifici.
– Musica e acustica: acero e tiglio per strumenti musicali, dove la qualità del suono dipende dalla fibra e dalla stagionatura.
6.Una lezione di modernità
La riscoperta dell’annotazione di Leonardo da Vinci, messa in luce da studiosi come Annalisa Di Maria, Andrea da Montefeltro e Lucica Bianchi, non è solo una curiosità erudita. È la dimostrazione di come il genio rinascimentale avesse intuito principi oggi alla base della scienza dei materiali e della bioarchitettura sostenibile.
Lo stesso trattamento che Leonardo suggeriva per preservare pali, travi e ingranaggi, oggi viene adottato da architetti contemporanei per rivestimenti, facciate e design ecocompatibile.
Il pensiero leonardesco, radicato nella conoscenza degli antichi ma proiettato nel futuro, continua a insegnarci che innovazione e tradizione non sono opposti, ma parti di un dialogo senza tempo.











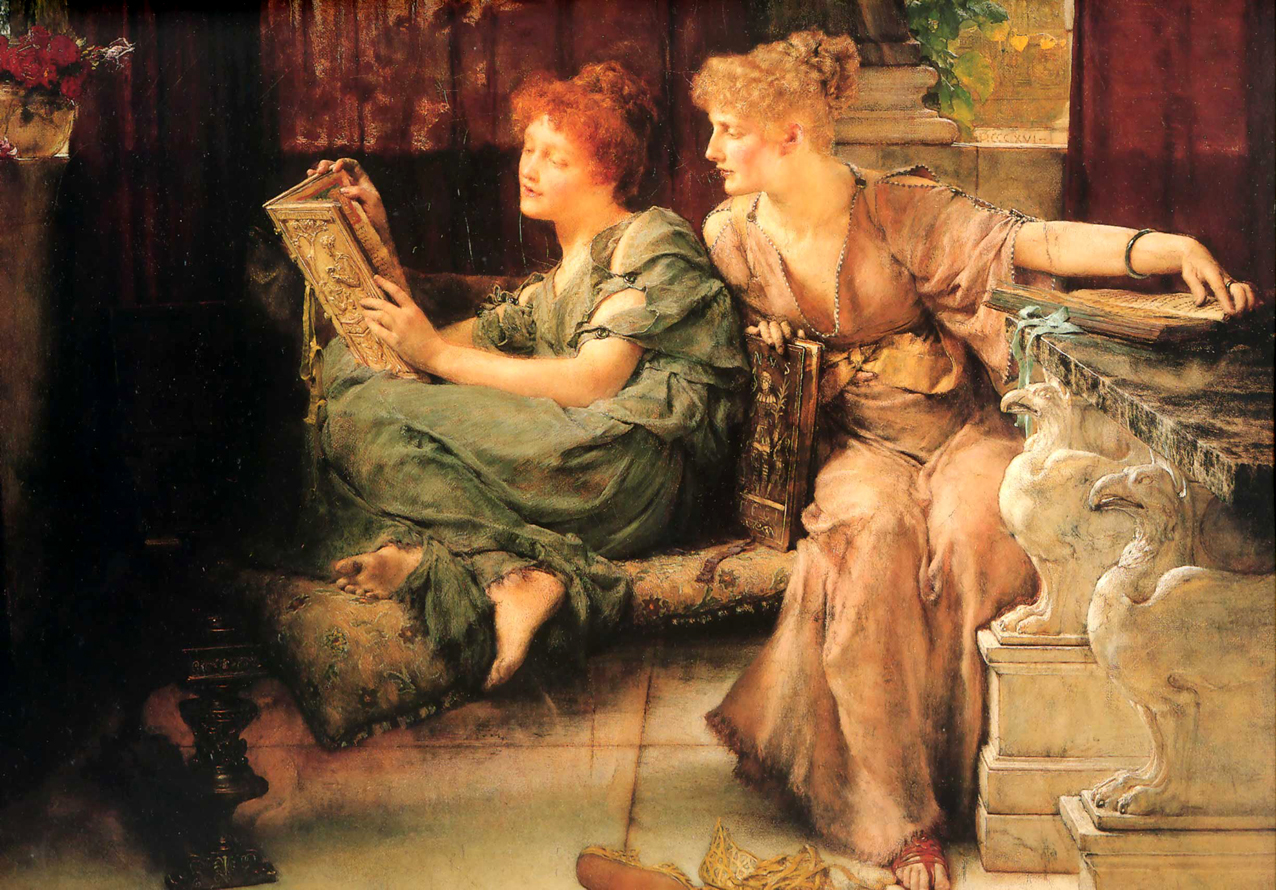

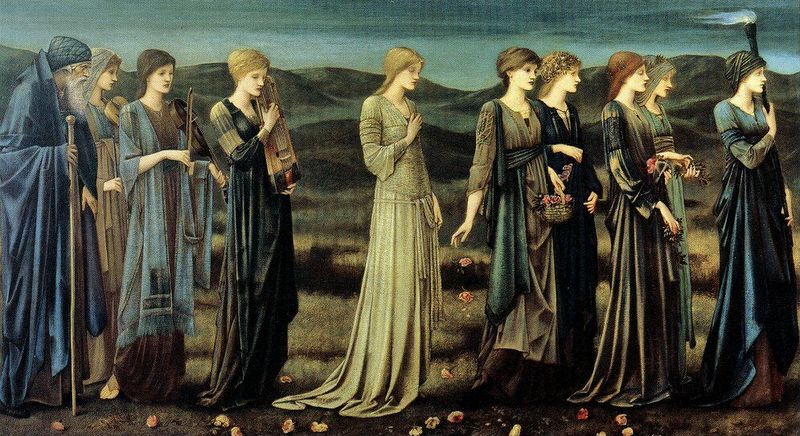





Social Profiles