A cura di Dario Stazzone
Nihil amantibus durum est, nullus difficilis cupienti labor.
San Gerolamo, Lettera ad Eustochio

Carlo Levi
Nel 1955 venne pubblicato Le parole sono pietre, terza opera di Carlo Levi dopo Cristo si è fermato a Eboli e Paura della libertà. La vicenda redazionale annovera complesse ipostasi. L’avantesto va individuato nei reportages realizzati dallo scrittore nel corso degli anni Cinquanta, e tra essi il resoconto del primo viaggio siciliano del 1951 pubblicato presso “L’Illustrazione italiana” e la rivista di Max Ascoli The reporter, col titolo Gente delle Madonie e il corredo fotografico di Giovanni Bosio. Nel 1952 il torinese effettua un nuovo viaggio in Sicilia, raccontato nel numero monografico de “L’ Illustrazione italiana” dedicato all’isola, in cui si apprezzano anche i contributi di Ercole Patti e Giovanni Comisso. Scopo del viaggio era verificare gli effetti della riforma agraria. Ancora in Sicilia nel 1955, Levi incontra il sociologo Danilo Dolci e Francesca Serio, la madre dolente di Turi Carnevale. Si tratta di due conoscenze essenziali, che daranno un senso profondo ai suoi viaggi siciliani. L’osservazione del mondo contadino e delle disperanti condizioni di vita degli zolfatai, la ricchezza delle suggestioni culturali di una terra estremamente complessa ed articolata, la violenza della mafia e gli impliciti della sua mentalità, le innovative pratiche politiche di Dolci e le denunzie della Serio che rompevano il costume dell’omertà sono tra i principali nuclei contenutistici del romanzo, connesso anche nel lessico e nelle isotopie semantiche al più noto Cristo.
Le tre fasi della poiesis
In un’intervista di poco successiva alla pubblicazione de Le parole sono pietre, intitolata L’invenzione della verità, Levi postulava tre fasi della poiesis che rappresentano le diverse possibilità della creazione artistica, illustrate attraverso le sue opere letterarie: «L’espressione di una realtà immobile» (Cristo si è fermato a Eboli); l’espressione di «una realtà che acquista vita e movimento» (L’Orologio); l’espressione dell’azione intesa anche come atto di parola (Le parole sono pietre). Il romanzo dedicato alla Sicilia, stando all’intentio auctoris, ha un ruolo nodale nella sua ricerca, connettendosi organicamente alla sua teoria creativa che investe parimenti la parola e l’immagine, il ritratto letterario come quello pittorico della Realtà:
Questa azione creatrice ha vari gradi. Nei miei libri mi pare si possa trovare, dapprima nel Cristo si è fermato a Eboli, l’espressione di una realtà immobile, la scoperta della relazione amorosa con la realtà immobile di un mondo distinto da sé, che in quel caso è il mondo contadino fuori della storia e del tempo, pieno di tutte le infinite realtà non in atto. Poi, attraverso questo rapporto amoroso, la realtà che ne nasce acquista vita e movimento. È il mondo dell’Orologio, animato e mosso dalla pura energia liberata, fuori dalla immobilità delle convenzioni. Poi questo movimento si obiettiva nell’azione, entra nella realtà come organismo, trova, drammaticamente, la sua giustizia, afferma la sua libertà, si apre alla parola: è il mondo di Le parole sono pietre. Ma questa successione che è avvenuta in me, e che si è espressa nei miei libri, mi pare sia la stessa che caratterizza dappertutto, e in tutti, il nostro tempo nel suo crescere e progredire.[1]
Per una teoria del linguaggio: l’equazione tra parola e poesia
Per comprendere pienamente Le parole sono pietre bisogna tener conto delle profonde sinopie intellettuali dell’autore e della formulazione di una teoria del linguaggio che si nasconde dietro le pagine apparentemente facili del romanzo.[2] Levi comincia a delineare, fin dai suoi esordi, una poetica variamente ripresa in diversi scritti saggistici e teorici, incentrata sulla necessità, per lo scrittore, di esprimere l’Ineffabile e per il pittore di trasformare il Reale in pittura. Occorre tener presente la capacità del torinese di utilizzare codici espressivi differenti, dalla prosa alla poesia alla pittura, per capire l’organicità della sua riflessione poietica che guarda a diversi codici espressivi. Levi fu un vero e proprio “autore doppio”, non solo scrittore ma anche pittore che, dopo gli esordi casoratiani e l’attraversamento di vari stilemi ispirati al post-impressionismo francese, approdò ad un originale idioma figurativo. Confrontandosi con le drammatiche cogenze del Novecento, l’autore del Cristo avvertì l’esigenza, per l’uomo e per l’artista, di uscire da uno stato di afasia e di silenzio, dando forma e consistenza immaginaria ad un Reale altrimenti muto, invisibile, inesistente, avendo così accesso al linguaggio ed alla storia, ossia alla Realtà. Per Levi l’attività poietica determina uno spazio di libertà che permette di ritrovare un «rapporto amoroso» col mondo, una relazione all’Altro che non sia segnata dalla schiavitù, dal terrore e dalla paura (la spinoziana deprecatio metus è infatti il tema centrale del saggio Paura della libertà, composto tra il 1939 e il ’40). La parola dell’artista non ha il compito di indagare ed approfondire la crisi della contemporaneità, né deve trasformarsi in pratica militante tout court. Essa, invece, deve autocrearsi continuamente come parola trovata per «la prima volta». E qualora questo non sia possibile a causa dell’inaridimento prodotto dalla crisi, è preferibile che l’artista taccia, scegliendo un provvisorio silenzio invece di realizzare un’arte accademica e priva di senso.
La parola poetica di cui parla Levi deve rompere il silenzio da cui pure scaturisce e creare la Realtà nel momento in cui di essa si dà la prima espressione. L’operazione creativa, definita sulla scorta di Giambattista Vico «mitologica» o «facoltà mitica»,[3] non deve nominare o rinominare un oggetto già esistente, ma lo deve fare esistere tramite un originario atto di parola, attraverso quel primo sforzo creativo che è condizione stessa dell’esistenza di un Soggetto. La scrittura, la pittura, l’azione (la militanza politica) non sono altro che forme specifiche dell’attività poietica che costruisce la Realtà. In questa prospettiva il termine poesia copre l’intero campo delle arti coincidendo col linguaggio stesso, inteso non come linguaggio pratico-convenzionale, denotativo, immediatamente referenziale, ma come linguaggio poetico, della polisemia e della parola vera. Memore della nozione vichiana di mito inteso come vera narratio, Levi riuscì a scorgere nella Lucania del confino, nella parola del mondo contadino così radicalmente altra rispetto alla retorica della romanità ed alle trite parole della borghesia locale, un vero e proprio universo poetico. Anche per questo l’esperienza confinaria, seppur non priva di difficoltà ed aspetti disforici, fu suscitatrice di «violenta poesia» e trovò espressione letteraria nel Cristo.
In questa prospettiva i viaggi siciliani e la scrittura de Le parole sono pietre ebbero un forte significato per l’itinerario intellettualedell’autore.Emblematica è la scelta del titolo del romanzo, passato da un troppo oleografico In pace con gli dei, allusivo dell’eterno mito della Sicilia solare ed apollinea, al ben più significativo Le parole sono pietre. La scelta non fu facile e coinvolse la migliore intelligenza italiana, nel dialogo che Levi intrattenne con Giulio Einaudi, Antonello Trombadori, Giorgio Amendola, Renato Guttuso, Alberto Moravia ed Elsa Morante. Le pietre verbali cui fa riferimento lo scrittore sono quelle scagliate da Francesca Serio, mater dolorosa che, dopo l’uccisione del figlio da parte della mafia, decise di denunziare esecutori e mandanti. Le parole della Serio, pronunziate in un dialetto stretto e difficile, furono tradotte per il torinese da Ignazio Buttita, autore a sua volta di una commosso Lamentu pi Turiddu Carnevali. La frase assurta a titolo del romanzo, nella prospettiva “mitica” dell’autore, diventa rappresentazione di un mondo sin lì marginalizzato, caratterizzato dall’afasia e dalla precarietà d’immagine, che attraverso un originario atto di parola si apre alla denunzia ed alla lotta. Le parole avvertite in corpore vili da una madre che aveva conosciuto il più disumano dei dolori diventano paradigmatiche dell’idea poietica leviana. Poste ad explicit del romanzo lo definiscono come una gradatio ascendente da una condizione originaria di sofferenza alla realizzazione di un mondo più umano.
Per una teoria del ritratto: Narciso e Cristo
Profondamente connessa alla teoria della parola è la teoria del ritratto che Levi tratteggiò fin dal 1935 sulla carta rara e preziosa di un quaderno carcerario, poco prima del confino lucano comminatogli per attività antifascista. Alle note dedicate al ritratto il torinese tornò con tre ampie chiose nel corso del 1968, quasi a rimemorare e verificare il suo percorso esistenziale e poietico. [4] Fin dagli scritti del 1935, partendo da un problema ben noto alla trattatistica rinascimentale, ossia il rischio per il pittore di scivolare nell’automimesis («Ogni pittore ritrae sé medesimo bene» aveva affermato Michelangelo e la celebre sententia era stata variamente ripresa da Poliziano, da Savonarola e da Leonardo nel Trattato sulla pittura), Levi aveva fatto di Narciso la figura centrale della sua riflessione sul ritratto. Lo scrittore, ben lungi dal teorizzare un narcisismo chiuso e patologico, aveva visto nel mito «pieno di grazia» l’immagine emblematica della tensione speculare che si apre al rapporto con l’Altro:
Se la prima immagine è quella di sé come altro, il ritratto è l’immagine dell’altro come se stesso, cioè come quella prima immagine fondamentale che è la capacità e possibilità stessa dell’immagine, che è se stesso come altro […] Questo Narciso rovesciato, che ripropone e ritrova quel suo archetipo, quella sua forma prima, in tutte le infinite cose, e vi si rispecchia per dimenticarsi di sé e per comprendersi, deve essere capace di intenderle tutte, di trovare in tutte una precedente esperienza comune, che le colleghi e le unisca, e le faccia reali non per l’amore di sé, ma per l’amore della propria rassomiglianza.[5]
Alla risemantizzazione del mito dell’orgoglioso efebo, già cantato dagli esametri dattilici delle Metamorfosi di Ovidio, non doveva esser estranea l’appassionata frequentazione della letteratura francese propria dell’ambiente gobettiano e venturiano in cui Levi si era formato, e in particolare l’influsso dei Fragments du Narcisse di Paul Valéry e Le traité du Narcisse di André Gide. Ma va ricordato anche il De Pictura di Leon Battista Alberti, che faceva del giovane intento a specchiarsi l’iniziatore del genere ritrattistico. Attraverso le immagini “mitiche” del «Narciso doppio» o del «Narciso rovesciato», Levi ha collocato la pulsione narcisistica, necessaria ed alienante ad un tempo per la letteratura freudiana, entro una salda cornice relazionale. La riflessione incentrata sull’«amore della propria somiglianza» (un sintagma che occorre negli scritti Sul ritratto e significativamente anche nella prefazione a L’uva puttanella di Rocco Scotellaro) interseca un altro motivo topico della trattatistica rinascimentale e barocca. Levi si chiede: «Quale è l’età e la forma dei corpi che le anime assumeranno alla fine dei tempi, al Giudizio finale? Si è detto, trentatré anni, l’età del Figlio, diversa forse per ciascuno, supposta, predestinata, e per ciascuno perfetta.» Dal saggio del torinese promana un evidente simbolico cristologico: la possibilità del ritratto nasce propriamente dalla somma di due immagini necessarie e fondamentali, quella di Narciso (l’adulescens al momento della fioritura fisica del corpo) e quella di Cristo, ossia dell’uomo giunto alla facies del suo perfetto sviluppo fisico e psichico, capace di amore verso la propria somiglianza. Levi tribuiva così un particolare significato al topos scritturale dell’Età del Figlio, la stessa che Cristo avrebbe avuto al momento della Crocefissione e della testimonianza del Golgota. Si tratta della rimodulazione originale di un tema lungamente discusso dalla trattatistica rinascimentale: Giulio Cesare Scaligero, affermando che la natura non può realizzare l’armonia e la perfezione che risiedono nella Forma, dimostrava che il ruolo dell’artista è di «elevare la natura o abbassare, aggiustare o dividere, curvandola o raddrizzarla.» Rivedendo criticamente la nozione aristotelica di mimesis intesa come imitatio naturae ed attingendo all’inesauribile dibattito sul rapporto tra la pittura e il suo referente, lo Scaligero dichiarava che la vocazione dell’arte è di essere al di sopra della natura. Per questo egli teorizzava l’esistenza di due soli ritratti «realistici», quello di Adamo, ossia dell’uomo prima della caduta, precedente il degrado che ha reso imperfetta la materia, e quello di Cristo, ossia la perfezione divina incarnata nell’uomo in virtù della gratia unionis. Di fronte a tutti gli altri modelli il pittore era invitato a correggere il reale. Il tema dell’imago Christi come perfetta immagine del corpo e del volto umano alligna in particolare nella letteratura italiana del XVI e XVII secolo. Anche per Levi l’immagine del Figlio è una realtà ideale, una matrice immaginaria che deve dialettizzarsi con la realtà.
Si noti la circolarità simbolica: quando lo scrittore vergava gli scritti sul ritrattoaveva esattamente trentatré anni e poco dopo avrebbe conosciuto il confino narrato poi nel Cristo. Il motivo cristologico, nel suo valore “mitico”, non allude semplicemente al martirio o alla testimonianza dello scrittore, ma più profondamente fa riferimento alla capacità di concepire il «rapporto amoroso» col mondo che è il presupposto ad una parola e ad un’immagine realmente significative. Levi ha dato dignità figurativa all’universo contadino dipingendo oltre settanta tele tra Aliano e Gagliano, usando poi quei dipinti, la cui aspra bellezza affascinava Moravia, come avantesto al Cristo. Lo scrittore concepiva l’atto pittorico come dialettica «amorosa» tra l’artista e il soggetto ritratto, come rapporto attivo tra esperienze e temporalità diverse. Egli agiva dunque, tra le argille malariche della Basilicata, come l’artefice di un processo di identificazione immaginaria e simbolica che vedeva una polarità attiva negli stessi contadini, determinandone, come Cristo con la sua novella amorosa, l’accesso al «fiume mobile» della storia.[6] L’incontro con l’universo lucano è stato l’occasione, per il giovane intellettuale torinese, di guardare finalmente «fuori dallo specchio dell’acque di Narciso»,[7] per i contadini di conoscersi specularmente e proiettivamente. L’identificazione con Cristo, nell’originale prospettiva leviana, è confermata dal tardo Quaderno a cancelli, ricognizione dell’intera sua vita e rimemorazione del confino che fu il vero clinamen della sua esistenza.[8]
Le teorie della parola e dell’immagine, condensate in saggi di respiro europeo come Paura della libertà e Paura della pittura,sono dunque un presupposto essenziale per comprendere l’opera leviana, troppo spesso collocata nell’ambito del regionalismo, del localismo o di una banale e immediata testimonianza militante.
«Il senso antico della giustizia fu toccato»: un mondo che si apre alla parola
Vincenzo Consolo ha commentato Le parole sono pietre, romanzo che a partire dal titolo («Mai titolo di libro fu più duro e capace di colpire») ha ritenuto modello di scrittura, intuendo il valore dell’amore leviano per «tutto quanto è umano»:
E mi sovvennero in quel momento, come concentrate in un’unica parola, le pagine del Cristo si è fermato a Eboli, le pagine di Le parole sono pietre e tutte le pagine da lui scritte sul mondo contadino. Concentrate in quest’unica parola: amore. Questo è la forza e la poesia delle pagine di Levi: l’amore per tutto quanto è umano, acutamente umano, vale a dire debole e doloroso, vale a dire nobile. Da qui quella sua straordinaria capacità di guardare, leggere e capire la realtà, capacità di leggere la realtà contadina meridionale, di comunicare con essa. Da questo suo amore, poi, l’ironia e l’invettiva contro il disumano, contro i responsabili dei mali, e la risolutezza nel ristabilire il senso della verità e della giustizia.[9]
Consolo ha insistito sulle differenze tra il romanzo di Levi dedicato alla Sicilia, caratterizzato da un «ritmo urgente», da una «febbre dello sguardo e dell’intelligenza», e il visus necessariamente più statico del Cristo. Ma nella prospettiva “mitologica” dell’autore Le parole sono pietre completa il percorso poietico iniziato con l’opera lucana. Il nesso è confermato dalle costellazioni lessicali e semantiche: nel territorio del feudo palermitano «l’orizzonte era chiuso», e «chiuso», con relative catene sinonimiche, è l’aggettivo che occorre ossessivamente nelle pagine incipitarie del Cristo; anche nella descrizione della Sicilia occorre il sostantivo «aridità» che ricorda l’isotopia «aridità»-«aridezza»-«arsura» presente nelle poesie del 1935-36 e nel romanzo confinario; tornano gli «occhi neri» dei contadini con la poetica variatio del «nero velluto degli occhi». In un caso il sintagma è inglobato nell’autocitazione di alcuni versi ispirati al confino: «Ma quanti altri occhi di uomini e di donne, neri, di un nero insieme vellutato e lucente, senza quell’ombra opaca dei piantidi infinite vigilie che fa nobile e terrestre lo sguardo dei contadini di Lucania, ma invece pieni di un fuoco, di un nero fuoco sfavillante, teneri insieme e feroci, languidi e miti e drammatici…»[10] Oltre al nero, di gran lunga dominante nel Cristo, Le parole sono pietre riconsegna altri colori propri delle descrizioni lucane, spesso connotati dall’uso del morfema modificante peggiorativo, come il «mare grigio-giallastro» del feudo; grigio e giallo sono ancora i colori principali nella zona delle zolfare, appena raddolciti dalle sfumature cromatiche dell’occaso: «Un ultimo velo di rosa, di porpora e di viola, appariva nel cielo grigio del freddo tramonto, sopra il giallo infernale della terra». Diversi altri nuclei tematici propri del Cristo occorrono nell’opera del 1955: gli «americani» è il termine con cui vengono definiti i migranti; i paesetti del palermitano non hanno conosciuto «altra storia che preistoria»; in essi, come nella Lucania magica e numinosa, «tutte le cose diventano vere»; la terra rivela la sua «solitudine arcana»; a Bronte, presso i cortili dei poveri, i bambini sono segnati dai sintomi della malaria, già al centro delle descrizioni lucane: «I bambini, dagli splendidi visi di angeli, hanno le pance gonfie per la malaria: è lo spettacolo della più estrema miseria contadina, inaspettata in questa costiera di paradiso…»
Le parole sono pietre, se letto con attenzione, rivela una fitta costellazione cristologica e rappresenta in modo originale l’idea poietica dell’autore, ossia l’accesso, da parte dei ceti subalterni, ad un’immagine e una parola umanizzante. Si tratta forse del romanzo leviano maggiormente caratterizzato dall’attenzione verso le diverse forme pittoriche (dalle barche decorate di Acitrezza ai carretti di Bagheria fino alle tele di Guttuso), alla fotografia ed al cinema (con raffinate chiose dedicate a La terra trema di Visconti).
La prima lessia rappresenta una parodica imitatio Christi: si tratta della trionfale visita di Impellitteri, un italoamericano divenuto sindaco di New York, al paesino natale di Isnello. I festeggiamenti e i discorsi dedicati all’«americano» non sono rappresentati con penna icastica, ma appena con qualche increspatura ironica e, in fondo, con una profonda comprensione, perché nella prospettiva contadina essi assumono un significato “mitico”: «Così, fin dal primo momento dell’ingresso, il viaggio del signor Impillitteri fu, per i contadini di Isnello, una avventura favolosa, un avvenimento mitico […] è diventato, questo viaggio, per gli isnellesi, una favola, e lo resterà, nel tempo, senza averlo voluto né preveduto: la favola della nascita e della Fortuna, la favola dell’America, dell’altra parte del mondo.» Impillitteri viaggia su una macchina ammirata e trattata dai concittadini come una «reliquia», perché toccarla propizierà un futuro viaggio negli States; il suo ritorno in Sicilia è paragonato ad una «epifania»; il luogo della sua «natività» si chiama «vicolo Gerusalemme». In esso il futuro sindaco di New York è nato in perfetta povertà, presso «una camera piena di paglia e di fieno, come Gesù Bambino». Levi rappresenta con ironia l’ordine delle somiglianze che lega Impillitteri agli abitanti di Isnello, l’ostentazione della consanguineità e persino dell’«albero ginecologico» da parte di un lontano parente. L’autore delle note Sul ritratto,che aveva fatto dell’immagine di Cristo il presupposto essenziale al ritratto stesso, rappresenta acutamente la proiezione identificativa dei isnellesi al loro idolo: «Il paese di Isnello festeggiava se stesso; ciascuno, in Impillitteri, riconosceva se stesso. Egli era come Cristo, un Dio-Uomo; ed era per la comune natura umana, anzi siciliana e isnellese, che tutti, signori e popolani, lo onoravano ed adoravano: perché era un uomo come gli altri, un siciliano come gli altri.» Ma ad Impillitteri, portatore di mercede e doni fallaci,[11] manca un passaggio essenziale della cristomimesi, quel martirio che accompagnerà invece le testimonianze tragiche e catartiche di ben altri uomini o donne descritti ne Le parole sono pietre. Quanto alla conclusione della misera epopea dell’uomo politico, Levi scrive: «E qui, con l’Adorazione e la Natività, finì la sacra rappresentazione nella quale il signor Impillitteri si era trovato ad essere artista ed attore. Nessuna crocefissione; nessun Golgota lo attendeva, del resto; ma un pranzo organizzato dalle monache dell’Orfanotrofio di Santa Maria…»
L’altro episodio di forte significato osservato da Levi nel primo viaggio siciliano del 1951 e narrato nel romanzoè la lotta dei lavoratori di una zolfara di Lercara Friddi, il paese natale dell’«americano» Luky Luciano. Il «signor B., valentissimo fotografo, armato di splendidi strumenti ed aggeggi, di miracolosi filtri e teleobiettivi» che accompagna il torinese è il fotografo Bosio. Il primo approccio col paese è descritto attraverso le connotazioni etopiche dei contadini e degli zolfatai, rappresentati per concrezione sineddochica dai volti e dagli sguardi: «La strada brulicava di gente; occhiate dritte ed occhiate oblique e traverse ci colpivano da tutte le parti. Si sentiva una tensione nell’aria, una passione comune, come se tutta quella gente, che non si capiva che cosa facesse, fosse mossa da cose profonde e importanti, aspettasse avvenimenti gravi e decisivi, che facevano vivi e attenti tutti i volti.» Levi, facendo riferimento allo sciopero dei minatori, commenta che, credendo di trovarsi in uno dei «mille paesi dell’immobilità contadina», si era invece trovato in un centro vivo e in pieno movimento. Le vicende di Lercara rappresentano per la prima volta, nell’ambito del romanzo, il terzo momento poietico teorizzato dallo scrittore, quello del «movimento che si concreta nell’azione». I minatori si erano mossi dopo la morte di un «caruso» di diciassette anni schiacciato da un masso, uno dei tanti Rosso Malpelo o Ciaula la cui sorte si è rivelata tristemente antifrastica al nome: Michele Felice. Così lo scrittore racconta l’inizio dello sciopero:
Alla busta-paga del morto venne tolta una parte del salario, perché, per morire, non aveva finito la sua giornata; e ai cinquecento minatori venne tolta un’ora di paga, quella in cui avevano sospeso il lavoro per liberarlo dal masso e portarlo, dal fondo della zolfara, alla luce. Il senso antico della giustizia fu toccato, la disperazione secolare trovò, in quel fatto, un simbolo visibile, e lo sciopero incominciò.[12]
Le lotte dei minatori erano iniziate in nome di un simbolo e di un’immagine, quella di Michele Felice, cui era stata intitolata la locale Lega degli zolfatai. Proprio all’interno della Lega si conserva il suo ritratto cui due crocefissi tribuiscono un evidente statuto martiriologico: «Sul muro di fondo era appeso un ritratto del ragazzo morto, di Michele Felice: non c’erano segni di partito né ritratti di uomini politici: era, quella del caruso morto, la sola immagine. Sotto di essa, un piccolo crocefisso, e un altro crocefisso più grande da un lato. Guardavano il ritratto del compagno morto con occhi di entusiasmo e quasi di riconoscenza. Di lì era cominciata, per loro, la vita, e il senso di essere vivi.» Guardando il dipinto gli zolfatai sembrano guardare in uno specchio e instaurare con esso una dialettica identificativa. Il ritratto, nel suo connotato martiriologico, ha per Levi una funzione morfogena che permette ai lavoratori di acquisire dignità di immagine, di accedere finalmente ad un ordine immaginario intimamente connesso a quello simbolico. I loro volti e i loro occhi, divenuti oculi lucentes, testimoniano il nuovo stato: «Parlando delle sventure, i loro occhi e i loro visi erano allegri, aperti e ridenti. Erano magri, alcuni sfigurati da infortuni, e molti, bambini e uomini, portavano in volto i segni della malattia, della turbercolosi e della vecchia fame. Ma pareva se ne fossero tutti dimenticati […] Erano facce nuove, facce di oggi, occhi che vedevano oggi le cose, fino a ieri nascoste, che vedevano se stessi.» Ricorrendo ad un facile statuto letterario, lo scrittore fa cenno all’ascensus dei lavoratori dall’inferno sulfureo della miniera alla nuova vita, attraverso una vera e propria «Resurrezione». L’acquisizione d’immagine da parte di uomini e donne, giovani ed anziani, determina una nuova disponibilità a farsi oggetto del ritratto fotografico: «Volevano tutti esser fotografati: avevano trovato il coraggio di esistere, non erano più nemici della propria immagine». Si ricordi che per Levi il ritratto (poco importa se pittorico o fotografico) è un processo poietico e dialettico che investe parimenti il pittore e il soggetto ritratto, che presuppone la relazionalità ed è totalmente estraneo alle gerarchie di potere. Ecco il perché, nella narrazione de Le parole sono pietre e nel suo universo simbolico, il losco proprietario della miniera di Lercara oppone una continua resistenza a farsi fotografare e viene immortalato solo grazie alla furbizia di B. Levi ne traccia un ritratto letterario caratterizzato da pochi elementi etopici e privo di riferimenti fisici: «Siamo nel 1951, e la faccia del signor N., contro cui lottano, non è di cento anni fa, ma di mille. Non è il viso di un industriale inglese del 1848, ma forse quello di un padrone di servi dell’ottavo o nono secolo, prima del Mille, e forse neppure quello…»
Le descrizioni successive confermano la pittorialità del romanzo, in un veloce susseguirsi di immagini e cromie che si fanno inno alla pulsione scopica e ad una certa inesausta cupiditas videndi. Bagheria, dopo un cenno statutario a villa Palagonia (che delude Levi come aveva deluso Goethe) ed ai carretti colorati dei fratelli Ducati, restituisce una significativa apertura paesistica rapportata alla pittura di Guttuso: «Questi angoli acuti e nervosi, quei colori aridi e violenti, quei rapporti di bianco e di giallo e di rosso, e di verde e turchino accostati (i colori dei carri) sono quelli dei quadri di Guttuso, che qui è nato; e qui (pensavo) si vede come la sua pittura sia vera e fedele alla terra». Singolare la descrizione delle mummie dei Cappuccini di Palermo. La loro rappresentazione si discosta significativamente dagli statuti dell’odeporica e dalla celebre rappresentazione che ne fece Maupassant. Levi vede nella raccolta di oltre ottomila corpi imbalsamati qualcosa di simile ad una galleria di ritratti, in cui l’essenza individuale è fermata e rappresentata per sempre (e si noti che, secondo gli scritti teorici del torinese, il ritrattista dovrebbe realizzare proprio quello che è accaduto nelle catacombe palermitane, rappresentando l’essenza del soggetto, la sua «totalità» e non le determinazioni particolari del momento): «…quel popolo di morti era ormai fermo nel tempo; e le lente modificazioni e decadenze di quelle pelli indurite, coperte di polvere e rose dai tarli, parevano soltanto accentuare i caratteri di una vita, di una storia individuale, tutta raccontata nei tratti del volto diventati essenziali nell’immobilità.» Di notevole valore la descrizione del centro storico di Catania, la «più bella città del Settecento», il cui significato appare subito chiaro alla sensibilità architettonica dello scrittore, formatosi fin dagli anni giovanili nel confronto con Lionello Venturi ed Edoardo Persico. Altri scorci descrittivi che declinano tutte le potenzialità dell’ipotiposi sono dedicati ai basalti lavici di Acitrezza, luogo mitopoietico per eccellenza, che determina la rimemorazione dell’opera verghiana e, naturalmente, de La terra trema di Visconti. Una figura del doppio dello scrittore, poco importa se reale o frutto di fictio letteraria, è intenta a dipingere lo scenario di Trezza: «Un pittore, venuto da Catania, aveva alzato il suo cavalletto e si adoperava a finire un suo quadro colorato di barche.» Subito dopo Levi, pittore della pagina come l’amato Tolstoj, descrive proprio le barche colorate che ricordano la Provvidenza verghiana.
L’ultima parte del romanzo è dedicata alla «gialla distesa del feudo coperta di stoppie», ai paesi del palermitano tristemente noti per il fenomeno mafioso. Si noti che Le parole sono pietre è tra i primi romanzi italiani che parlano apertamente di mafia, condannando le troppe reticenze relative al fenomeno criminale. Avanzando tra «montagne funeste» e «pendici selvagge di pietre», Levi giunge a Trappeto ed al Borgo di Dio di Danilo Dolci. L’architetto e sociologo triestino che aveva adottato una delle zone più povere della Sicilia per organizzare pescatori e contadini nella logica della non violenza, che sperimentava innovative pratiche didattiche e che nel 1956 avrebbe subito un assurdo processo per l’organizzazione di uno “sciopero alla rovescia”, ossia di uno sciopero effettuato lavorando per realizzare opere di pubblica utilità, appare a Levi «amichevole e aperto». Il territorio di Trappeto è ricco di «disfiziati» e «industriali», due termini che il torinese annota con solerzia.[13] «Disfiziati» è una determinazione dialettale che indica uomini senza lavoro, senza più volontà o desideri, mentre gli «industriali» (termine di cui Levi si ricorderà in Un volto che ci somiglia) sono quelli che si industriano, che non avendo un lavoro né proprietà vivono alla giornata di espedienti. Dolci viene rappresentato come un uomo «che ha fiducia, che ha fiducia negli altri (una fiducia generale nell’uomo)» e il romanzo descrive subito la dinamica per oculos e la tensione proiettiva che lo investe: «In quella totale destituzione gli occhi guardavano tuttavia Danilo con un lume di speranza, e una certa vaga speranza anche in se stessi mi pareva leggervi di riflesso.» Cuore della lessia è il ritratto del fondatore di Borgo di Dio che si sofferma sul significante degli occhi vivaci e sull’interna energia dell’uomo, quell’«energia» che è altro significante essenziale per Levi (come lo era per l’amato Stendhal) e che è il presupposto all’azione poietica: «Entrammo nella casa di Danilo che ci accolse amichevole e aperto: alto, robusto, con una nordica testa complessa, gli occhi vivaci dietro gli occhiali, allegro di una interna energia, sempre presente, sempre rivolto, anche nei minimi gesti, all’azione.»
Al breve ritratto letterario del 1955 Levi fece seguire, nel ’56, un ritratto pittorico del triestino. In questo caso la transcodificazione dei linguaggi segna una dinamica inversa rispetto a quella delle tele del confino lucano che funsero da appunti pittorici per la scrittura del Cristo. Il ritratto dell’autore di Banditi a Partinico succede all’ipotiposi letteraria e rappresenta, per cenni compendiari, il processo che indignò la migliore intellettualità italiana, nel quale Dolci fu difeso da Piero Calamandrei.[14] La mite figura dell’uomo campeggia al centro del dipinto, i polsi stretti dalle manette e le mani sovrapposte le une alle altre. Nell’impossibile motilità del corpo, dietro agli occhiali trasparenti, si scorge tutta la forza del suo sguardo, vero punctum di promanazione semantica dell’opera. Attorno a Dolci, ma su un piano leggermente arretrato, sono i suoi contadini, uomini, donne e bambini, con gli abiti della festa, le donne chiuse negli scialli neri, i volti contriti in un dolore dignitoso e trattenuto. Nello sfondosi scorgono due carabinieri, facilmente riconoscibili dall’uniforme, e in lontananza tre giudici. A sovrastare il tutto ed a dare un senso alla vicenda di Dolci è un crocefisso. Lateralmente, a destra, si scorge una finestra che definisce un quadro nel quadro, aprendosi sull’arido paesaggio siciliano.
Ad explicit del romanzo Levi colloca l’incontro con la Serio, una delle tante madri presenti nella sua opera letteraria e pittorica che, lungi da voler tutelare il tradizionale assetto matriarcale e mafioso della realtà in cui vive, parla una parola forte di denunzia. Lo scrittore, attraverso il racconto di un accompagnatore, traccia in primo luogo il ritratto del figlio: «Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle riunioni contadine. Aveva trentadue anni, alto, bruno, scuro di pelle, nero di occhi e di capelli, pieno di fuoco e di energia, anche un buon oratore era, deciso, violento, estremo, ma insieme molto equilibrato e con una visione precisa e semplice delle cose. Era uno dei migliori, un vero capo contadino.» Torna nel ritratto di Carnevale, perfettamente equilibrato tra etopea e prosopografia, il sostantivo «energia» accanto all’allusione al fuoco oratorio del capo contadino, fondatore della Camera del Lavoro in un paese dall’antico assetto feudale. L’azione di Carnevale era caratterizzata da un’«intransigenza» che ricorda un’altra parola-chiave cara a Gobetti e dunque al Levi formatosi nella Torino gobettiana: «aridità». L’aridità, intesa come assoluta intransigenza morale, era per Gobetti un imperativo categorico e un presupposto alla militanza politica. Carnevale se ne faceva interprete in un territorio arretrato e mafioso: «Capì che l’intransigenza è un dovere morale, una necessità di vita, e che il primo passo è l’organizzazione…» Sfidando la principessa, discendente di un’antica famiglia di feudatari, invocando la riforma agraria, occupando le terre e chiedendo la riduzione dell’orario di lavoro il contadino di Sciara era divenuto estremamente scomodo. A trentadue anni, quasi trentatré (l’Età del Figlio), anche Carnevale è stato ucciso col rituale mafioso che ne ha sfigurato il volto: «L’assassinio era, per così dire, firmato, con la simbologia delle uccisioni di mafia: i colpi al viso, per sfigurare il cadavere, in segno di spregio; e il giorno seguente il furto di quaranta galline, per il banchetto tradizionale.» Nella narrazione leviana emerge un ruolo attivo della madre anche quando il giovane sindacalista era in vita: a lei si era rivolto un soprastante offrendole per il figlio la migliore tenuta d’olive, facendo seguire oscure minacce se egli non avesse accettato l’offerta e non avesse interrotto l’attività politica.
Prima d’incontrare la Serio, Levi descrive con attenzione il paese Sciara, il suo castello alto su una roccia che domina l’abitato e che appare, manzonianamente, «militare e grifagno». Lo sviluppo verticale del luogo permette di osservare dall’alto ogni casa, ogni via e porta sottostante, «come in un grande quadro senza ombre». La polarità tra alto e basso, la catechesi architettonica, i simboli di un potere ancora medievale fanno dire a Levi: «Pareva un’immagine araldica della Sicilia feudale, troppo semplicistica, troppo simbolica per essere vera».
Tra le case dei contadini, «invisibili» ed adagiate ai piedi della rocca, Levi conosce la Serio e la descrive con lapidee similitudini, nella bellezza dura, nella determinazione violenta. È la digressione ipotipotica più ampia del romanzo, il ritratto più attento e dettagliato, capace di restituire, con concinnitas, una sequenza di cinque predicati e di ben sette determinazioni aggettivali poste in successione asindetica:
È una donna di cinquant’anni, ancora giovanile nel corpo snello e nell’aspetto, ancora bella nei neri occhio acuti, nel bianco-bruno colore della pelle, nei neri capelli, nelle bianche labbra sottili, nei denti minuti e taglienti, nelle lunghe mani espressive e parlanti: di una bellezza dura, asciugata, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana […] ci fa sedere vicino a lei, presso quel letto bianco che era quello di Salvatore, e parla. Parla della morte e della vita del figlio come se riprendesse un discorso appena interrotto per il nostro ingresso. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta intera: la sua vita di contadina, il suo passato di donna abbandonata e poi vedova, il suo lavoro di anni, e la morte del figlio, e la solitudine, e la casa, e Sciara, e la Sicilia, e la vita tutta, chiusa in quel corso violento e ordinato di parole. Niente altro esiste in lei e per lei, se non questo processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo del feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Essa stessa si identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta in un giorno: le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono pietre.[15]
Il discorso della Serio muove da un’incrollabile certezza, da un’idea di giustizia che è la «realtà della propria azione» da cui scaturisce l’atto di parola. Ripercorrendo la vita del figlio e la sua stessa vita tra echi scritturali, ella rende esplicito il simbolico cristologico e martiriologico che attraversa il romanzo. Così commenta Levi: «Anche per lei il figlio è Cristo, ma in un modo del tutto realistico (col brigadiere che come Pilato dice: ̶ Non è competenza mia ̶ ), legato alla terra. E che non chiede amore, ma giustizia.» Il Cristo che alligna nelle ultime pagine de Le parole sono pietre, etimologicamente humilis e mosso da un’idea superiore di giustizia, ricorda quello pugnace e implacabile del Vangelo secondo Matteo. Carnevale, poco prima del suo assassinio, aveva salito a suo modo la scala di Giacobbe ed aveva risposto ad un mafioso che lo minacciava: «Chi uccide me uccide Gesù Cristo». La stessa frase è ripetuta dalla Serio davanti a Levi. Il martirio del figlio e la sua radicale cristomimesi avevano cambiato la donna, le aveva permesso l’accesso alla parola che avrebbe determinato uno dei primi processi alla mafia delle campagne palermitane. Anche la «nera madre», ben consapevole dei rischi delle denunzie, percorreva così la sua imitatio Christi, disposta alle estreme conseguenze della sua testimonianza.
Ad esergo della vicenda di Sciara e delle parole della Serio si potrebbe collocare una notazione leviana che evoca la Scrittura: «Il suo discorso è un Vangelo, un povero, poliziesco Vangelo di verità, una testimonianza di verità. Questo solo conta per lei; mentre parla giungono dalla chiesa vicina i rintocchi della campana. Non arresta il suo dire, ma vedo che fa rapidamente il suo segno della croce e mormora: ̶ Santa campana, testimone di verità.»
[1] C. Levi, L’arte e la libertà, in Id., Coraggio dei miti, a cura di G. De Donato, De Donato editore, Bari 1975, p. 54.
[2] Per la teoria leviana del linguaggio si veda R. Galvagno, Carlo Levi, Narciso e la costruzione della realtà, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2004, pp. 99-133.
[3] C. Levi, Paura e coraggio dei miti, in Id., Prima e dopo le parole. Scritti e discorsi sulla letteratura, a cura di G. De Donato e R. Galvagno, Donzelli Editore, Roma 2001, pp. 57-59.
[4] Quanto alla riflessione leviana sul ritratto mi permetto di rinviare a D. Stazzone, Carlo Levi. Per una teoria del ritratto. Dalla paura della libertà al neoumanesimo, tesi di laurea dissertata presso la Facoltà di Lettere di Catania, relatrice R. Galvagno, correlatori G. Savoca e A. D’Aquino.
[5] C. Levi, I ritratti, in Id., Lo specchio. Scritti di critica d’arte, a cura di P. Vivarelli, Donzelli Editore, Roma 2001, p. 9.
[6] Si ricordi quello che Levi scriveva ad incipit di Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1945, p. 3: «Cristo non è mai arrivato qui, né vi è mai arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia.»
[7] Levi usa questa espressione rimemorando il confino lucano in Lettera dell’autore all’editore del giugno 1963, posta in premessa a Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1963.
[8] C. Levi, Quaderno a cancelli, Einaudi, Torino 1978. Nella scrittura continua e magmatica del Quaderno, a p. 5, si legge: «…e soprattutto malgrado tutto serissimo Cristo barbuto e bello che appare, destinato a dileguarsi e a sparire per mancanza di permanenza, di presenza, di sostegno (il Cristo è diventato una specie di guerriero di profilo e spettinato, classicamente allegro, ridente senza ragione, come Stefano fenicio idiota sulla spiaggia).» Levi, nel periodo di redazione dell’opera, era ricoverato in clinica a causa di un intervento all’occhio destro, ciò che faceva labile il suo visus. Durante la convalescenza, rafforzandosi la vista, si era ritratto con la barba lunga, come si descrive nell’opera letteraria, identificandosi con Cristo e col «guerriero birmano», altra ricorrente figura del doppio.
[9] V. Consolo, Prefazione a C. Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, Torino 2010, p. VI.
[10] I versi sono citati da Levi nella Lettera dell’autore all’editore, cit., e tornano ripetutamente in diverse altre sue opere, come Un volto che ci somiglia. Ritratto dell’Italia: «Occhi neri che i pianti / d’infinite vigilie / fatto han vuoti, guardate / nel profondo dell’anima.»
[11] Come il podestà Luigi Magalone, nel Cristo si è fermato a Eboli, si era affaccendato a realizzare un monumentale e inutile orinatoio nel cuore del paese di Aliano, così le donazioni di Impillitteri serviranno a realizzare, presso Isnello, delle docce pubbliche che non verranno mai utilizzate. Così commenta Levi: «Tuttavia non potei fare a meno di ammirare la divina inutilità del dono. Chi mai farà la doccia nelle docce di Impy? Esse saranno, di certo, un intoccabile oggetto di adorazione.» Cfr. C. Levi, Le parole sono pietre, cit., p. 24
[12] Ibidem. P. 43.
[13] Le occorrenze dei due termini rinviano al modus operandi di Levi, che con metodo ambientista annotava, durante i suoi viaggi, termini, frasi, espressioni idiomatiche, canzoni, filastrocche, favole e quant’altro ritenesse interessante sui suoi taccuini, usati poi come avantesto ai romanzi in cui si costituiva narratore intradiegetico.
[14] Cfr. P. Calamandrei, In difesa di Danilo Dolci, Quaderni di Nuova Repubblica, Firenze 1956.
[15] C. Levi, Le parole sono pietre, cit., p. 139.













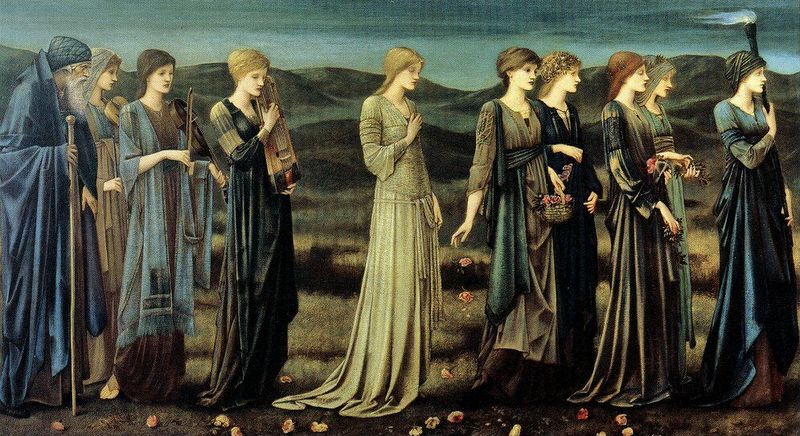





Social Profiles